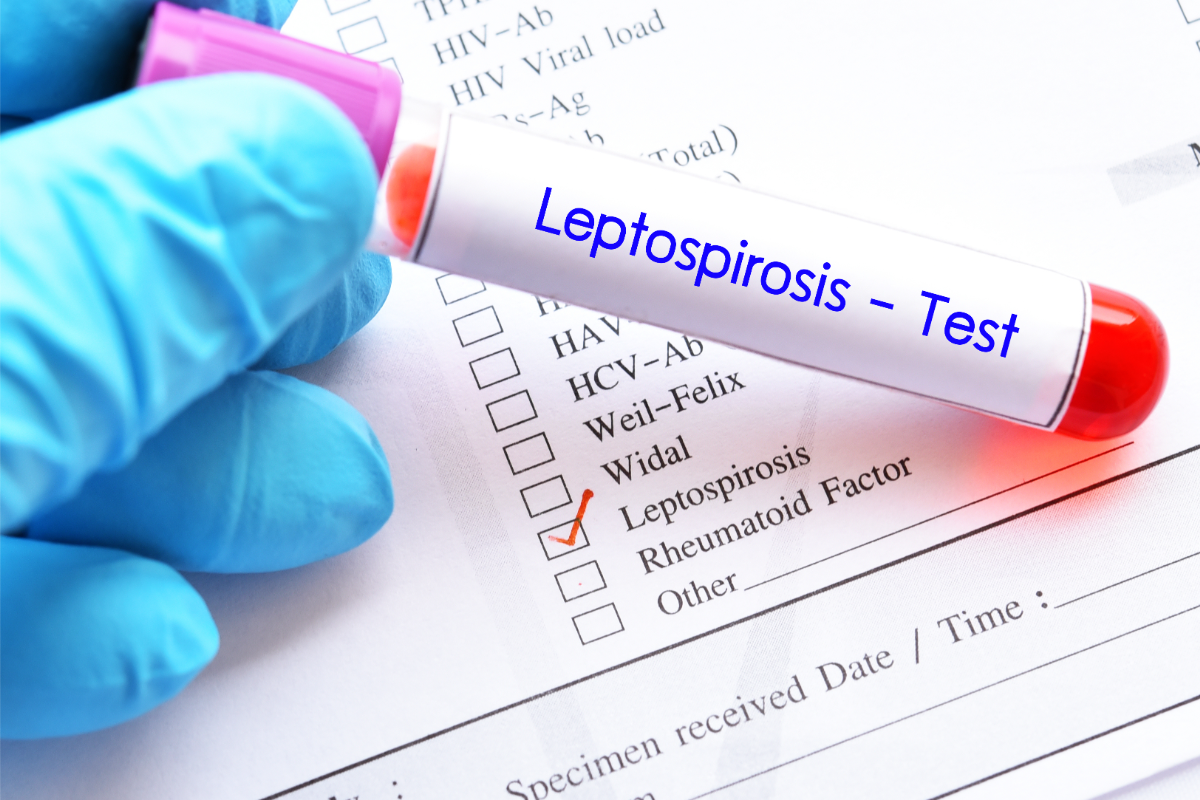La leptospirosi è una malattia infettiva batterica che colpisce principalmente gli animali, ma può colpire anche l’uomo. Causata da batteri del genere Leptospira, questa zoonosi è spesso sottovalutata nonostante le sue implicazioni potenzialmente gravi per la salute pubblica. Si trasmette principalmente attraverso l’esposizione all’acqua o al suolo contaminati dall’urina di animali infetti, in particolare roditori.
Quale batterio è responsabile?
La leptospirosi è una malattia infettiva di gravità variabile, causata da batteri del genere Leptospira, dell’ordine delle Spirochete. I batteri patogeni del genere Leptospira comprendono diverse specie, tra cui Leptospira interrogans, di cui esistono più di 250 varietà note come sierovari. Le più comuni nella Francia continentale sono L. icterohaemorrhagiae, L. australis, L. sejroe e L. grippotyphosa.
Si tratta di antropozoonosi, malattie comuni all’uomo e agli animali (mammiferi). I principali serbatoi sono i roditori selvatici (portatori sani), seguiti dai cani e dal bestiame (suini, cavalli, bovini). Il genere Leptospira comprende anche specie saprofite, non patogene, come L. biflexa, che vivono nel suolo e nell’acqua dolce e non infestano gli animali. Nel corso dell’evoluzione, alcune specie si sono adattate ai tubuli renali dei mammiferi. Esse causano la leptospirosi nell’uomo e negli animali domestici.
Leptospira interrogans è l’agente patogeno responsabile della leptospirosi. Nel 2017, il genere Leptospira comprendeva 22 specie, tra cui 10 patogeni, e più di 300 sierovari suddivisi in 24 sierogruppi. I sierogruppi più importanti sono icterohaemorragiae, canicola, pomona, australis, grippotyphosa, hyos e sejroe. Questa diversità rende difficile la progettazione di vaccini efficaci contro tutte le leptospire.
I batteri Leptospira hanno una lunghezza compresa tra 6 e 20 micrometri e un diametro di 0,1 micrometri. È aerobico e cresce lentamente a 27-30°C su terreni speciali. Si presenta come un filamento a spirale, flessibile e mobile, con estremità uncinate e un endoflagello terminale costituito da un paio di flagelli periplasmatici. Questa struttura gli conferisce mobilità e velocità. Ciò facilita la sua diffusione nei tessuti e la sua capacità di eludere i meccanismi di difesa immunitaria come la fagocitosi.
Dall’inizio del XXI secolo, una nuova classificazione basata sul genoma tende ad affiancare quella tradizionale basata sugli antigeni.
Come si presenta la malattia negli animali?
La leptospirosi è una malattia infettiva causata da batteri patogeni del genere Leptospira. È diffusa in tutto il mondo, con un’incidenza particolarmente elevata nelle aree tropicali. In Europa, la situazione varia da Paese a Paese.
Tutti i mammiferi possono essere infettati dalle leptospire. Le specie suscettibili, come il bestiame, gli animali domestici e quelli da passatempo, possono sviluppare la malattia; il cane è la specie più suscettibile. Le specie poco o per nulla suscettibili, soprattutto i roditori, possono espellere i batteri attraverso l’urina. Alcune specie sensibili, come castori e volpi, possono ospitare il batterio, anche se la loro suscettibilità non è ben nota.
La trasmissione avviene principalmente attraverso il contatto delle membrane mucose o della pelle lesa con l’acqua dolce, il suolo o un ambiente contaminato dall’urina di animali infetti. Le leptospire possono sopravvivere per diverse settimane in acqua dolce. La trasmissione può avvenire anche attraverso fluidi biologici contaminati, principalmente l’urina di animali infetti.
I segni clinici variano da specie a specie. Nei cani, i danni al fegato e ai reni possono causare la morte entro pochi giorni senza trattamento. Cavalli, bovini e suini possono presentare problemi riproduttivi. I roditori sono generalmente asintomatici, ad eccezione di castori, criceti e porcellini d’India, ma sono portatori di reni.
Nei cani, la leptospirosi è dovuta principalmente a Leptospira canicola e L. interrogans. I cani infetti sviluppano rapidamente febbre e vomito. Il trattamento si basa sulla terapia antibiotica. È disponibile un vaccino veterinario, anche se la sua efficacia può essere limitata contro alcune leptospire.
Nei bovini e negli ovini, la leptospirosi può causare perdite economiche per gli allevatori, compromettendo la riproduzione e la produzione di latte. Nei cavalli possono verificarsi complicazioni oculari.
Come si trasmette?
La leptospirosi si trasmette attraverso il contatto con le mucose o con la pelle lesa. La trasmissione avviene principalmente attraverso l’esposizione all’acqua dolce, al suolo o a un ambiente contaminato dall’urina di animali infetti, dove le leptospire possono sopravvivere per diverse settimane. Anche i liquidi biologici contaminati, in particolare l’urina, sono vettori di trasmissione.
Le professioni a rischio includono lavori a contatto con acqua dolce o terreni umidi sporchi di urina di roditori (ratti, nutrie, topi e topi). Sono particolarmente a rischio gli addetti alle fognature, il personale degli impianti di trattamento delle acque, gli addetti alla manutenzione delle sponde dei fiumi, gli allevatori di pesci, i guardiani della pesca e i lavoratori in ambienti acquatici. Possono essere a rischio anche gli allevatori, i veterinari, i lavoratori dei macelli, gli addetti alle svendite e gli addetti alla manipolazione degli animali che entrano in contatto con roditori domestici.
Il batterio penetra generalmente nella pelle . La penetrazione sembra essere facilitata da una rottura della pelle o da una pelle ammorbidita dall’esposizione prolungata all’acqua. La contaminazione può avvenire anche attraverso le membrane mucose, spruzzando acqua sporca in bocca, nel naso o negli occhi. L’inalazione di aerosol è meno comune. Anche le attività ricreative come il nuoto, la pesca, il kayak e il rafting aumentano il rischio di trasmissione.
Dopo aver penetrato la pelle o le mucose, le leptospire passano nel flusso sanguigno e migrano in tutti i tessuti. Il periodo di incubazione e la gravità dell’infezione dipendono dalla quantità di leptospire inoculate.
Le leptospire, presenti nell’acqua in seguito agli escrementi di animali contaminati, penetrano nell’organismo attraverso ferite, erosioni cutanee, membrane mucose o per inalazione. Gli esseri umani sono ospiti occasionali di leptospire patogene, che circolano tra animali selvatici e domestici.
Come si manifesta la leptospirosi nell’uomo?
Il periodo di incubazione della leptospirosi varia da 1 a 3 settimane, di solito tra 7 e 14 giorni. La malattia presenta diverse forme cliniche. Queste possono variare da sintomi simil-influenzali a malattia multiviscerale con sindrome emorragica, rendendo difficile la diagnosi. Il tasso di mortalità è compreso tra il 5% e il 20% in assenza di trattamento o se il trattamento viene ritardato. La leptospirosi è tipicamente bifasica, ma talvolta può essere monofasica e fulminante. La diagnosi è più probabile in estate, quando le persone sono esposte all’acqua dolce o alle rive dei fiumi per lavoro o per svago.
Le due fasi della leptospirosi
La leptospirosi inizia con una fase setticemica, in cui le leptospire si moltiplicano nel sangue e danneggiano i piccoli vasi sanguigni attraverso la vasculite. Questo provoca febbre grave e dolore diffuso. Successivamente, le leptospire si attaccano a vari organi (fegato, reni, cervello, cuore), rendendo difficile la diagnosi. Questa fase inizia bruscamente, con mal di testa, mialgie intense, brividi, febbre, tosse e talvolta emottisi. Gli occhi diventano rossi, di solito intorno al 3° o 4° giorno. La fase setticemica dura da 4 a 9 giorni.
Dopo la fase setticemica, tra i giorni 6 e 12 si verifica una fase immunitaria, caratterizzata dalla comparsa di anticorpi nel siero. I sintomi ricompaiono, con una nuova febbre e segni di meningite. Possono verificarsi anche disturbi oculari come iridociclite, neurite ottica e neuropatia periferica. Le complicazioni polmonari possono essere gravi in caso di emorragia polmonare. Questa fase dura generalmente da 4 a 30 giorni.
L’interessamento renale porta all’escrezione di leptospire nelle urine, ma questo avviene troppo tardi per aiutare la diagnosi. Negli esseri umani non esistono portatori sani e non costituiscono un serbatoio di trasmissione.
Se infettata durante la gravidanza, la leptospirosi può portare all’aborto spontaneo, anche durante la convalescenza. La malattia nell’uomo può essere grave se non trattata, con un tasso di mortalità compreso tra il 5% e il 20%. Le forme gravi possono includere insufficienza renale, disturbi neurologici (convulsioni, coma) ed emorragie potenzialmente fatali.
È fondamentale consultare un medico se si sviluppa la febbre entro due settimane dal nuoto o dal gioco in acqua dolce e segnalare qualsiasi attività di questo tipo.
Forma classica: malattia di Weil
La leptospirosi ittero-emorragica o malattia di Weil è una forma clinica classica di leptospirosi. Combina ittero e danno renale (epatonefrite) con disturbi emorragici. La malattia è causata dalla Leptospira interrogans, principalmente dalla serovar icterohaemorrhagiae, anche se sono possibili altre serovar.
Un tempo considerata la forma più grave di leptospirosi, gli specialisti vedono oggi la malattia di Weil come una forma più comune e meno grave nei Paesi sviluppati.
Le manifestazioni cliniche variano in intensità. Nella maggior parte dei casi non sono molto gravi, ma possono evolvere imprevedibilmente in disturbi gravi con un tasso di mortalità superiore al 10%.
L’esordio è improvviso, con una grave sindrome infettiva (febbre alta, brividi, astenia) e dolore (cefalea, dolori muscolari). L’ittero compare dopo 2-8 giorni e raggiunge il suo picco in 2 giorni, producendo un “ittero fiammeggiante”. Questa fase dura circa 10 giorni, seguita da una tregua e da possibili ricadute.
Il danno renale, caratterizzato da albuminuria e ridotta produzione di urina, può progredire fino all’insufficienza renale acuta che richiede l’emodialisi. I disturbi emorragici comprendono petecchie, epistassi e gengive sanguinanti, con frequente trombocitopenia. Possono verificarsi gravi emorragie nelle vie respiratorie, digestive e urogenitali.
Rare complicazioni come la meningite e il danno d’organo multiplo (cardiovascolare, polmonare, shock settico) possono richiedere una rianimazione specifica. La sindrome di Weil può portare a febbre, ittero, insufficienza renale e tendenza emorragica. Anche i polmoni e il cuore possono essere gravemente colpiti.
In assenza di ittero, il recupero è completo. In presenza di ittero, il tasso di mortalità è del 5-10%, che sale al 40% nei casi gravi, soprattutto nei pazienti di età superiore ai 60 anni. Il rischio di morte aumenta in presenza di complicazioni come l’insufficienza renale, l’insufficienza respiratoria e l’emorragia interna.
Forma influenzale
La forma influenzale della leptospirosi, che rappresenta circa l’80% dei casi, è più comune della forma classica. L’esordio della malattia è improvviso, con uno stato infettivo grave: febbre superiore a 39°C, brividi, mal di testa, accompagnati da mialgie e dolori diffusi prevalentemente agli arti inferiori, in particolare dolori invalidanti ai polpacci, aggravati dalla pressione.
L’esame clinico può rivelare diversi segni distintivi, tra cui emorragia congiuntivale, herpes labiale e talvolta epatomegalia dolorosa. Più raramente, può comparire un esantema sul tronco. Questa fase iniziale della malattia dura da 3 a 7 giorni, durante i quali la febbre torna gradualmente alla normalità.
Se non trattata, può verificarsi una ricaduta. I sintomi iniziali ricompaiono, generalmente meno intensi, ma accompagnati da segni meningei e disturbi neurologici. Questi segni comprendono torcicollo, forti mal di testa e talvolta sintomi più gravi come le convulsioni. In seguito possono comparire anche complicazioni oculari, in particolare uveiti di origine immunologica, causate da autoanticorpi.
La fase iniziale della malattia simil-influenzale è caratterizzata da febbre alta, forti dolori muscolari, cefalea e brividi. Questi sintomi possono imitare quelli dell’influenza. Ciò rende difficile la diagnosi clinica senza un’anamnesi di esposizione a fattori di rischio per la leptospirosi.
La forma influenzale della leptospirosi è caratterizzata da una presentazione iniziale grave ma spesso aspecifica. È poi seguita da una possibile ricaduta con complicazioni neurologiche e oculari. Questa forma anitterica di leptospirosi è la più comune. Rappresenta la maggior parte dei casi e richiede una particolare vigilanza per una diagnosi e un trattamento precoci.
Altre forme
Qual è il trattamento appropriato?
Il trattamento standard per la leptospirosi è un antibiotico a base di penicillina (penicillina G o ampicillina) o una ciclina come la doxiciclina. Si tratta di un trattamento antibiotico probabilistico che deve essere iniziato precocemente e che dura da 7 a 10 giorni. Questo trattamento antibiotico precoce ha praticamente eliminato le forme croniche gravi della malattia, in particolare le complicanze oculari autoimmuni.
In caso di complicazioni viscerali e metaboliche, possono essere necessari metodi di rianimazione, come la dialisi per l’insufficienza renale persistente. Una reazione di Jarisch-Herxheimer, dovuta alla lisi delle spirochete, è comune dopo l’inizio del trattamento.
Il paziente si riprende entro 5-6 settimane se la malattia è moderata. Tuttavia, i batteri possono essere ancora presenti nelle urine diverse settimane dopo la scomparsa dei sintomi. Le forme gravi di leptospirosi hanno un tasso di mortalità superiore al 10% in tutto il mondo, ma nei Paesi con infrastrutture mediche moderne la mortalità è prossima allo zero.
Per le forme gravi, i medici somministrano corticosteroidi, anche se la loro efficacia è oggetto di dibattito. Il trattamento antibiotico viene somministrato precocemente per ottenere la massima efficacia. L’isolamento non è necessario, ma occorre prendere precauzioni per eliminare l’urina.
Il trattamento delle forme gravi richiede il ricovero in ospedale con rianimazione medica e somministrazione di antibiotici il prima possibile. Le cefalosporine di terza generazione (ceftriaxone e cefotaxime) e l’azitromicina sono i trattamenti di prima linea. Le cicline possono essere proposte in caso di allergia. Le leptospire sono solitamente sensibili ai β-lattamici, ai macrolidi e alle cicline.
È disponibile un vaccino (SPIROLEPT®) per la profilassi della leptospirosi dovuta al sierogruppo Icterohaemorrhagiae negli adulti ad alto rischio.
Quali sono i mezzi di prevenzione?
Le azioni a livello di serbatoio comprendono:
- Controllo dei roditori: derattizzazione, eliminazione delle fonti di cibo e di rifugio, gestione dei rifiuti in contenitori chiusi, progettazione dei locali.
- Gestione ambientale: drenaggio dei prati umidi, eliminazione delle acque stagnanti.
- Sorveglianza sanitaria: dichiarazione e gestione degli aborti negli allevamenti.
- Isolamento e trattamento degli animali malati: se si allevano animali, trattamento curativo.
- Vaccinazione degli animali: adeguata alle specie interessate.
Per limitare la trasmissione, è necessario
- Limitare il contatto con l’acqua dolce nelle aree frequentate dai roditori.
- Evitare qualsiasi contatto diretto con animali selvatici, vivi o morti.
- Organizzare i siti di lavoro: identificare i roditori e le aree umide se si lavora in ambienti umidi o infestati.
- Trasporto sicuro: di rifiuti e cadaveri in contenitori sigillati ed etichettati.
- Pulizia e disinfezione: dei siti contaminati e delle attrezzature di servizio riutilizzabili con un battericida autorizzato.
- Strutture igieniche: armadietti separati per gli abiti da lavoro e quelli da strada, acqua potabile, sapone, materiali monouso per la pulizia e una cassetta di pronto soccorso concordata con il medico del lavoro.
- Informazioni sull’assunzione e regolarmente aggiornate
- In laboratorio, seguire le buone prassi in conformità alle normative vigenti.
Per la prevenzione individuale , ci si affida a :
- Dispositivi di protezione individuale: guanti resistenti e impermeabili, stivali o trampolieri, tute impermeabili, occhiali protettivi a seconda dell’attività.
- Rispetto delle istruzioni igieniche
I laboratori francesi preparano il vaccino SPIROLEPT® a partire da batteri inattivati di L. interrogans serovar Icterohaemorrhagiae. Questo vaccino è destinato agli adulti ad alto rischio. Il programma di vaccinazione prevede due iniezioni a distanza di 15 giorni l’una dall’altra, un richiamo da 4 a 6 mesi dopo e poi ogni 2 anni se l’esposizione persiste.
In medicina veterinaria, i cani vengono generalmente vaccinati contro quattro sierogruppi: L. Canicola, L. Icterohaemorrhagiae, L. Australis e L. Grippotyphosa.
Alcuni dati epidemiologici…
La leptospirosi non è una malattia animale obbligatoria (Regolamento 2016/429). Tuttavia, è una malattia umana soggetta a notifica. Le autorità riconoscono la leptospirosi come malattia professionale per la quale è previsto un indennizzo ai sensi della tabella 5 del regime agricolo e della tabella 19 del regime generale. Le autorità classificano tutti i sierovari di Leptospira interrogans nel gruppo 2 (articolo R.4421-3 del Codice del lavoro francese, ordinanza del 16 novembre 2021).
La leptospirosi è una malattia diffusa in tutto il mondo, con un’incidenza particolarmente elevata nelle regioni tropicali. Nella Francia continentale colpisce ogni anno circa 600 persone (da 0,4 a 1/100.000 abitanti). L’incidenza è da 50 a 100 volte superiore nelle regioni tropicali. Si stima che ogni anno nel mondo si verifichino più di un milione di casi gravi, con un tasso di mortalità superiore al 10%. La malattia è altamente stagionale, con picchi durante la stagione delle piogge nelle regioni tropicali e in estate/autunno nei Paesi temperati.
Alcune professioni (agricoltori, allevatori, addetti alle fognature, raccoglitori di rifiuti) e attività ricreative in acqua (nuoto, canoa, kayak, pesca, caccia, canyoning) presentano rischi maggiori.
L’epidemiologia varia a seconda dell’ecosistema e delle condizioni di vita. In Francia, il numero di casi è aumentato da 300 a circa 600 all’anno dal 2014. Le regioni meridionali e la Franca Contea sono le più colpite. Nei dipartimenti francesi d’oltremare l’incidenza è da 10 a 80 volte superiore a quella della Francia continentale.
Le ragioni di questa emergenza sono molteplici: riscaldamento globale, aumento delle popolazioni di roditori e attività ad alto rischio. La segnalazione sistematica dei casi di leptospirosi a partire dall’agosto 2023 ha lo scopo di valutare meglio la malattia, identificare le popolazioni a rischio e attuare misure di controllo adeguate.